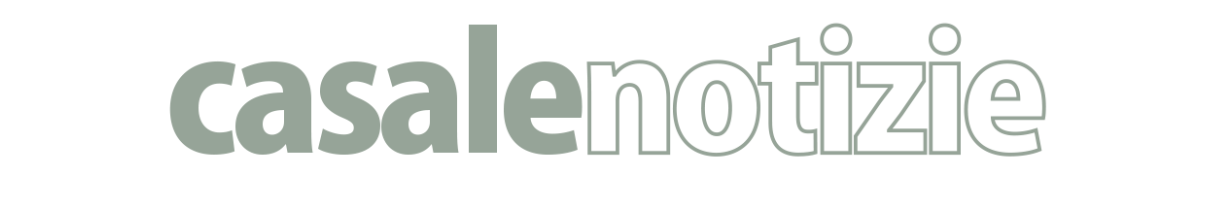Case di autentica pietra
Paesi e cascine del Monferrato spiccano per una tonalità ocra gialla: il colore della pietra da cantoni. Un materiale che ci parla della storia e della cultura di questa zona, cui è dedicato lEcomuseo di Cella Monte, che oggi compie 10 anni
Paesi e cascine del Monferrato spiccano per una tonalità ocra gialla: il colore della pietra da cantoni. Un materiale che ci parla della storia e della cultura di questa zona, cui è dedicato l?Ecomuseo di Cella Monte, che oggi compie 10 anni
 CASALE MONFERRATO – Hanno milioni di anni e sono entrati nelle nostre case. Li hanno scavati gli uomini in cava e nelle cantine, per farne blocchi di forma squadrata. Non c’è un poggio, qui, né un crinale, che non ne abbia almeno un po’: e per lunghi anni sono stati ricoperti. Troppo misera la loro origine (qui, sotto terra), troppo chiara la necessità (convenienza) di chi li ha scavati a mano, sotto casa, tirandoli in superficie a farne mura e pilastri, perché non sembrassero “poveri”. I blocchi di pietra chiara che costituiscono le case, le chiese, i cascinot del Monferrato, sono stati per molti lustri coperti da intonaco.
CASALE MONFERRATO – Hanno milioni di anni e sono entrati nelle nostre case. Li hanno scavati gli uomini in cava e nelle cantine, per farne blocchi di forma squadrata. Non c’è un poggio, qui, né un crinale, che non ne abbia almeno un po’: e per lunghi anni sono stati ricoperti. Troppo misera la loro origine (qui, sotto terra), troppo chiara la necessità (convenienza) di chi li ha scavati a mano, sotto casa, tirandoli in superficie a farne mura e pilastri, perché non sembrassero “poveri”. I blocchi di pietra chiara che costituiscono le case, le chiese, i cascinot del Monferrato, sono stati per molti lustri coperti da intonaco. Giù nella pianura, già si facevano mattoni con le fornaci: le case avevano un altro colore, un altro suono a picchiettarle con la mano. Ma su in collina, nel Monferrato Casalese, ere geologiche sepolte lasciavano affiorare, nel primo sottosuolo, quel sedimento marino che va sotto il nome di pietra da cantoni. A dispetto dell’opinione comune, che la crede tufo (di origine vulcanica, mai apparso qui) è con essa che le comunità dei paesi hanno costruito i loro nuclei abitati, oltre alle stalle, ai cascinali e ai depositi campestri. Cavandone dalle miniere aperte fino a qualche decennio fa a Rosignano, a Cereseto, Camino, Ozzano e in pochi altri centri. Il resto era materiale di scarto, ricavato dall’apertura – in inverno, mentre le vigne riposano – di celle sotterranee, sotto le abitazioni, dove si conserva il vino e si andava nei giorni d’estate a respirare un po’ di frescura: gli infernot.
Vino e colline sono emblema del Monferrato Casalese. Ma l’unità inscindibile di costruito e ambiente naturale si coglie appieno dalla prospettiva della pietra da cantoni: le colline da cui si estrae il materiale per costruire le case; le cantine sotto di esse, scavate nella stessa pietra di cui sono fatti gli edifici, e in cui si conserva il vino che matura sui colli. 
Il caso più eclatante di riscoperta dell’antica partitura in pietra è proprio quello dell’Ecomuseo. L’ex casa parrocchiale che ospita l’Ente, sorge nel centro di Cella Monte e si presentava come un’anonima casa un po’ antiquata. Il geometra Gianni Ottone, che ha curato i lavori, racconta: “abbiamo cominciato a rinforzare il tetto e a riquadrare le finestre quando … sotto il rivestimento di mattoni posticcio è apparsa una colonna, con arcata e capitello. Il disegno cinquecentesco della facciata era stato completamente tamponato, lasciando sepolti e intatti due loggiati sovrapposti, uno a quattro e l’altro a sei archi, in pietra da cantoni”. Il risultato è straordinario: l’elegante edificio, che somiglia all’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli, è unico nel suo genere. I lavori sono stati interrotti e poi riaperti per le dovute analisi della sovrintendeza: il primo piano aprirà tra un anno, si auspica, mentre il resto dovrà attendere ulteriori finanziamenti.
Nei secoli, i cambiamenti architettonici hanno seguito il gusto estetico e le tecniche costruttive. Così, alla fine degli anni ’50, tutte le cave di questo materiale sono state abbandonate: mattoni e altro materiale industriale erano più comodi da impiegare, mentre gli standard richiesti per il lavoro in miniera rendevano l’attività estrattiva non più conveniente. 
Paradosso della modernità, non c’è più oggi una cava attiva in Monferrato, e la pietra usata in edifici di nuova costruzione è tutta di recupero, oppure viene impiegata della pietra di area leccese, simile ma non identica all’originale. Uno studio di P. Sassone valuta le possibilità di riapertura di un sito estrattivo, ma è ancora pura ipotesi.
Quel che più conta, è la presa di coscienza del valore della cultura locale. Come in Valsesia con le case Walser, come in Puglia con i trulli o con le grotte a Matera, i materiali un tempo considerati “poveri” perché reperibili in loco mostrano il lato autentico del territorio e della cultura che li ha impiegati. “Questi edifici hanno reso il Monferrato un tesoro per chi lo visita. Di tutti i luoghi che hanno saputo valorizzare il proprio patrimonio, ce se ne innamora, con ricadute gastronomiche e turistiche”, dice ancora Gianni Ottone.
Non è un caso che a settembre torni “Arte e Natura”, esposizione collettiva promossa dall’Ecomuseo con opere di artisti che hanno scelto il Monferrato come patria adottiva: il valore del territorio non è una questione di localismo, ma ha a che fare con la bellezza, questa sì universale.