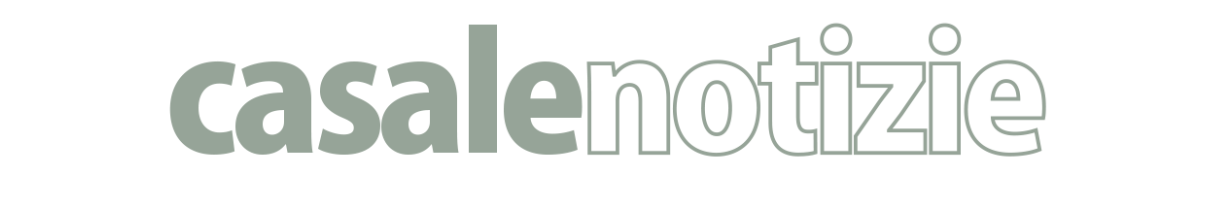Il Nobel per la Medicina per come le cellule si “mangiano”
L'autofagia è un processo fondamentale per degradare e riciclare i componenti delle cellule. Il processo è noto da oltre cinquant'anni, ma la sua fondamentale importanza è stata riconosciuta solo dopo la ricerca del professor Yoshinori Ohsumi. Per le sue scoperte, gli viene assegnato questanno il Premio Nobel
L'autofagia è un processo fondamentale per degradare e riciclare i componenti delle cellule. Il processo è noto da oltre cinquant'anni, ma la sua fondamentale importanza è stata riconosciuta solo dopo la ricerca del professor Yoshinori Ohsumi. Per le sue scoperte, gli viene assegnato quest?anno il Premio Nobel
 SCIENZA – L’autofagia è un processo fondamentale per degradare e riciclare i componenti delle cellule. Il processo autofagico è un fenomeno noto da oltre cinquant’anni, ma la sua fondamentale importanza è stata riconosciuta solo dopo la ricerca del professor Yoshinori Ohsumi. Per le sue scoperte, gli viene assegnato quest’anno il Premio Nobel in fisiologia o medicina.
SCIENZA – L’autofagia è un processo fondamentale per degradare e riciclare i componenti delle cellule. Il processo autofagico è un fenomeno noto da oltre cinquant’anni, ma la sua fondamentale importanza è stata riconosciuta solo dopo la ricerca del professor Yoshinori Ohsumi. Per le sue scoperte, gli viene assegnato quest’anno il Premio Nobel in fisiologia o medicina.A metà degli anni ‘50 del Novecento, gli scienziati avevano già osservato un nuovo compartimento cellulare specializzato, contenente enzimi in grado di catabolizzare, ovvero degradare, proteine, carboidrati e lipidi. Questo comparto specializzato fu battezzato con il nome di “lisosoma”. Una scoperta così importante che venne premiata con il Premio Nobel per la medicina nel 1974 allo scienziato belga Christian de Duve.
Altre osservazioni nel corso degli anni’60 avevano mostrato come una grande quantità di materiale cellulare poteva, a volte, essere rinvenuta all’interno dei lisosomi. La cellula quindi sembrava avere una strategia per “consegnare” il materiale di scarto ai lisosomi.
Ulteriori analisi biochimiche e indagini microscopiche rivelarono l’entità e il funzionamento del sistema di trasporto al lisosoma (Figura 1), organizzato in vescicole. Christian de Duve coniò così il termine di “autofagia”, dall’inglese “auto-eating” (autodigestione), e le vescicole (ovvero i trasportatori verso i lisosomi) furono nominati “autofagosomi”.
All’avvio del suo laboratorio nel 1988, il professor Ohsumi, utilizzando cellule di lievito, concentrò i suoi sforzi sulla degradazione delle proteine nel vacuolo, un organello simile ai lisosomi delle cellule umane. Le cellule di lievito sono relativamente facili da studiare e di conseguenza sono spesso usate come modello per studi di biologia cellulare e molecolare.
Ma Ohsumi dovette affrontare una sfida importante: le cellule di lievito sono piccole e le loro strutture interne non sono così facilmente visibili al microscopio, e quindi era incerto se l’autofagia fosse veramente presente anche nel lievito. Pensò giustamente che se fosse riuscito a interrompere il processo di degradazione nel vacuolo, mentre il processo di autofagia era attivo, le vescicole di trasporto, ovvero gli autofagosomi, ripiene di materiale di scarto, avrebbero dovuto accumularsi all’interno del vacuolo, diventando così visibili al microscopio.
Egli coltivò quindi cellule di lievito mutato mancante degli enzimi di degradazione vacuolari e contemporaneamente stimolò l’autofagia “affamando” le cellule. I risultati furono sorprendenti: in poche ore infatti, i vacuoli si riempirono di piccole vescicole, cariche di materiale non degradato. Le vescicole erano autofagosomi e l’esperimento di Ohsumi dimostrò che il processo di autofagia esisteva anche nelle cellule di lievito.
Ma ancora più importante, Ohsumi ora aveva un metodo per identificare e caratterizzare i geni chiave coinvolti in questo processo. Nel giro di pochi anni della sua scoperta nel lievito, il professor Ohsumi aveva identificato i primi geni essenziali per l’autofagia. Nei suoi studi successivi, identificò anche le proteine codificate da questi geni, chiarendo il processo di attivazione dell’autofagia.
Grazie alle osservazioni di Ohsumi e ad altre scoperte, ora sappiamo che l’autofagia ha importanti risvolti fisiologici per degradare e riciclare vari componenti cellulari.
L’autofagia può rapidamente fornire “combustibile” per le attività cellulari per superare i blocchi energetici per il rinnovo dei componenti cellulari, ed è quindi essenziale per la risposta alla fame e ad altri tipi di stress. Dopo un’infezione, inoltre, l’autofagia è in grado di eliminare l’invasione di batteri intracellulari e virus.
L’autofagia contribuisce poi anche allo sviluppo embrionale e al differenziamento cellulare. Le cellule utilizzano anche il fenomeno dell’autofagia per eliminare le proteine e organelli danneggiati (come i mitocondri nel processo definito “mitofagia”), un meccanismo di controllo di qualità che è fondamentale per contrastare le conseguenze negative dell’invecchiamento.
In sintesi, il processo di autofagia è essenziale per mantenere l’omeostasi e le funzioni cellulari, e l’autofagia è responsabile della degradazione lisosoma-mediata delle proteine e degli organelli danneggiati, e quindi una alterazione dell’autofagia può risultare in una varietà di condizioni patologiche. Anche se la nostra comprensione dei percorsi regolatori che controllano l’autofagia è ancora limitata, un crescente numero di studi hanno messo in luce l’importanza dell’autofagia in una vasta gamma di processi fisiologici e di patologie umane, come diabete, malattie neurodegenerative, malattie infettive e cancro.
Yoshinori Ohsumi è nato nel 1945 a Fukuoka (Giappone). Ha ottenuto il dottorato di ricerca all’Università di Tokyo nel 1974. Dopo aver lavorato tre anni alla Rockefeller University di New York (Usa) ha fatto rientro all’ateneo nipponico dove ha formato il suo gruppo di ricerca nel 1988. Dal 2009 è professore al Tokyo Institute of Technology.
Figura 1: Le nostre cellule hanno diversi comparti specializzati. I lisosomi costituiscono un compartimento, od organello cellulare, rivestito di membrana e contengono enzimi per la digestione dei contenuti cellulari. Un tipo di vescicole chiamato “autofagosoma” è presente all’interno delle cellule. Gli autofagosomi raccolgono vari contenuti cellulari, come le proteine e organelli danneggiati, e poi si fondono con i lisosomi, dove il materiale cellulare viene degradato in costituenti più piccoli. Questo processo fornisce la cella con sostanze nutritive e di blocchi costruttivi per il rinnovo (immagine tratta da Nobelprize.org)