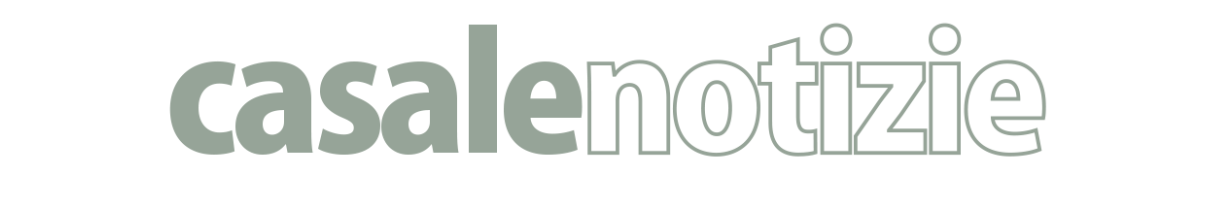Le lotte di un tempo per i confini di Valenza
L'approfondimento del professor Maggiora
VALENZA – Il Medioevo ha consegnato all’epoca moderna un territorio solcato da confini in cui i cambiamenti di frontiera erano frequenti e controllati dai vari signori. Il Comune di Valenza, assediato da vicini non troppo amichevoli, è sempre stato in lotta, anche con bassezze e meschinità, forse inevitabili, contro di chiunque tentasse di occupare o impossessarsi del suo territorio.
I diritti dei privati non corrispondevano sempre alle pretese di chi governava gli uomini e i territori, erano più le abitudini, i comportamenti consolidati, le occupazioni quotidiane e gli spostamenti a determinare il tracciato delle linee di confine. Mancavano le regole dello stare insieme e spesso s’incendiavano gli animi e si spegnevano i cervelli; non era possibile il diverbio, solo la belligeranza, nella speranza che fosse l’altro a frenare per primo. Un quadro «impeccabile» che ha offerto prove continue di amenità e diverse perle che vado a riassumere.
La storia dei confini tra il territorio di Valenza e quello di San Salvatore Monferrato Villa ad Vites in antichità, Castrum Sancti Salvatoris dal 1048 e S.Salvatoris Montisferrati in quest’epoca, è disseminata di prolungate liti nel corso di diversi secoli, sia per l’instabilità dei governi dei due stati, Ducato di Milano per Valenza e Marchesato di Monferrato per San Salvatore, sia per i ricorrenti cambiamenti a seguito delle numerose pretese dei singoli proprietari, esibite con alterigia e atteggiamenti baldanzosi. Sono molte le liti e le contrapposizioni avvenute già nel Trecento, alcune chiuse come peggio non si poteva, spesso con accordi di cartapesta. A ogni azione aggressiva corrispondeva una reazione uguale o peggiore «a scopo difensivo».
Negli anni 1442-1443, c’è stata una lunga vertenza per delimitare il confine tra i due comuni, una tappa fondamentale nella definizione della fascia di territorio che dalla regione di Astiliano andava fino alla regione Anda, attraverso le frazioni di Frescondino e Valparolo, dove erano collocate alcune chiesette campestri. A designare i confini si ponevano delle croci, ma c’era una croce dubbia, oggetto di confutazione, che si trovava alla biforcazione di due strade, di cui una portava alla pieve di Astigliano e l’altra al poggio di Primo. Più sotto, vi era la regione chiamata Castello Ravasino e, nei pressi, esisteva anche la chiesa di S. Lorenzo, che, secondo gli abitanti di S. Salvatore, sarebbe stata sul loro territorio, mentre secondo i valenzani era sul territorio di Valenza e addirittura era stata edificata da loro stessi, come dimostrava un’iscrizione posta sopra l’architrave di detta chiesa. Un’altra chiesa vicina, detta S. M. di Francia si trovava nella regione chiamata il Piano di Francia, poi Frescondino.
Poiché si trattava di confini tra due signorie, quasi una guerra non dichiarata ufficialmente, con colpevole ritardo il duca di Milano Filippo Maria Visconti (1392–1447), l’ultimo duca di Milano della dinastia viscontea, e il marchese del Monferrato Gian Giacomo Paleologo (1395–1445) riuscirono a dirimere la controversia pacificamente: un tentativo acrobatico ma tutto sommato riuscito.
Da Milano fu inviato il vicario generale Agapito Lanfranchi, mentre il Marchese del Monferrato mandò Guglielmo dei conti di Montiglio, poi sostituito dal giureconsulto Secondino Natta signore di Isola d’Asti, verboso e gonfio di retorica ma abile nel sopravvivere. Sostenevano le parti i procuratori Giacomo Basti e Ludovico Mombello per Valenza e Rainero Raselli e Ghisello Ricci per San Salvatore, mentre Andrea Franghia era incaricato di descrivere i confini. Alla fine del lungo procedimento, con pazienza, sagacia e abilità negoziale, riuscirono a concludere l’accordo, una specie di costituzione non troppo favorevole per Valenza. Dimenticando però che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, e la pace, se non è equanime, non è pace.
In buona sostanza, nella chiesa della Beata Vergine di Francia, luogo dello svolgimento della contesa, tra i numerosi testimoni, o sedicenti tali, che si accusano reciprocamente di professare il falso, giurarono in favore di Valenza Domenico Bellone, Marsilio Stanchi, Antonio Selvatico, Michele Franghia, Massimo Colli, Giovanni Dente, Aimoneto Mombello, Antonio Lancia, Giovanni Amisano e altri. Il confine concordato tra Valenza e San Salvatore doveva essere marcato con croci di legno, cosa che ai tempi sembra essere stata ritenuta una condizione eccellente ma torbida come usanza e d’incertezza durevole. Nell’occasione, la situazione non si era appesantita, in verità nemmeno troppo alleggerita, ma questo sarebbe stato insensato sperarlo: hanno lavorato molto anche per far ridere. Evidentemente i rapporti non ottimali tra i due stati non hanno aiutato, perché a volte fare le vittime sono alibi per nascondere la propria ignavia o incapacità.
Poi, verso la metà del Seicento, tornava in auge un’altra gravissima e lunga controversia tra Valenza e San Salvatore, sempre per ragioni di confini, che si protrasse per parecchi anni con velenose scaramucce, una consolidata consuetudine animata dal rancore più profondo, dimostrando oltre ogni ragionevole dubbio l’assoluta inefficacia degli accordi.
Sempre sul versante monferrino, anche il Comune di Lazzarone era in continua lotta con Valenza per ragioni di confini. Detta terra era sotto i Visconti del Monferrato, che anticamente dominavano anche a Valenza, ma che poi si erano ritirati nelle regioni limitrofe monferrine. Già dal 1348 si levarono furiose dispute ma non si trovarono soluzioni efficaci e un secolo dopo, Gaspare da Vimercate (1410 circa – 1467, talvolta nella forma Gaspare Vimercati) dal 1454 conte feudatario di Valenza, un algido e superbo condottiero di ventura con famiglia di origini valenzane al servizio di Francesco Sforza e a lui molto familiare, condusse una mediazione con i signori di Lazzarone.
Quale autorità prescelta, per dirimere quelle controversie confinarie, egli stipulò una macchinosa convenzione tra le due parti il 25 giugno 1460, ma qualcosa non andrà a genio a molti e le liti non saranno sopite. Infatti, nel 1565, sono nuovamente documentati dissidi tra le due comunità, con comportamenti inopportuni e vergognosi, contrasti che saranno reiterati un secolo dopo, nel 1676. Sembra che quelli di Lazzarone, facendo finta di non vedere, non volessero conformarsi alla convenzione del 1460, che i valenzani ponevano sempre avanti, e si appellassero al fatto che tale convenzione non avesse mai avuto l’approvazione dei legittimi superiori.
A ogni buon conto, un’altra sentenza draconiana che non lasciava spazio a dubbi del 22 giugno 1594 era già stata approvata dal Senato, nella quale si disponeva favorevolmente per Valenza circa la fissazione di confini tra i due territori di Valenza e di Lazzarone, di cui allora era consignore (consorziato nel feudo) Anselmo Visconti, mentre il conte di Valenza (una figura controversa, possessore del Feudo) era Mercurino III Gattinara Lignana. Entrambi poco avvezzi alle critiche, alimentarono pian piano torti e ragioni innescando un infinito botta e risposta, con la volontà struggente di essere fedeli al loro passato sbagliato o giusto che fosse. Per molti si trattava di accordi fittizi, di espedienti per tenere buoni i contendenti mentre il potere era di volta in volta mutante: una contrapposizione ostinata e permanente. Nessun concreto ravvedimento o ripensamento per portare i contendenti lungo il cammino della prudenza che avrebbe fatto buona guardia ai loro vicendevoli interessi, solo la soppressione del Comune di Lazzarone-Villabella e l’accorpamento a Valenza nel XX secolo risolveranno ogni dissidio in merito con un unico avverbio: finalmente.
Oltre all’opera dell’uomo, erano spesso i fiumi a tracciare lo spazio di separazione tra due territori. Ad accrescere l’imbarazzante quadro generale locale, a nord di Valenza, lungo il fiume Po, nascevano vivissimi dissidi con il Comune di Bozzole a causa delle isole fluviali dette Val Longo e, mentre Valenza era sostenuta dal Comune di Sartirana, le pretese territoriali di Bozzole erano appoggiate dal Comune di Pomaro, che, mostrando dei muscoli che non aveva, inneggiava a chi faceva opposizione al posto suo.
Gli scenari che si crearono a causa dei disaccordi restarono aperti per diversi anni del Cinquecento, con il contorno inesorabile di risse e minacce, sulle quali si hanno notizie da una documentazione del 1582, in occasione di un nuovo contenzioso per il possesso di un’altra isola detta Piarda Rossa.
Permalosi, uno più dell’altro, anche questi dissidi causarono incidenti, di cui alcuni penosi, come il sequestro di convogli fluviali diretti a Valenza da parte del Comune di Bozzole, cosa che gli mise contro anche i comuni di Breme e Sartirana interconnessi. Con accuse e controaccuse, le liti, che spesso imponevano di menare le mani, proseguirono, toccando il picco nel 1586 e nel 1601. Un corto circuito impossibile da isolare, dove si giocava irresponsabilmente a mettere in difficoltà anche chi stava governando e a buttare carburante sul fuoco tra interlocutori inaffidabili.
Tutte queste terre appartenevano anticamente alla potente famiglia valenzana dei Guazzo, che non rispondeva a nessuno se non a se stessa, e che, pur essendo regredita dal suo antico splendore e troppo moderna per i tempi, abitando abitualmente a Valenza conservò sempre qualche possesso, quasi a testimonianza della primitiva potenza.
Per alcuni lustri permase la linea dell’intransigenza a prescindere, un concetto irremovibile sul territorio fluviale del Po, una situazione spesso protesa sull’orlo del precipizio, in cui incessanti litiganti seguitavano a recitare il solito rosario con un’ostinazione integralista. Non si capiva cosa si potesse fare per spegnere l’incendio, gli interessati facevano di tutto per ostacolarsi, con un sentimento tracotante di giustizia, riassunto in uno slogan: fargliela pagare, cercando di arrecare danno. Uno stallo insuperabile piuttosto avvilente.
Anni dopo, ci si trovava di fronte ad un’altra lite fra gli stessi e di una quarta lite si accenna in una carta del 27 giugno 1772, stesa in un rigido rococò di eufemismi e di perifrasi, che reca la seguente dicitura: «Conclusioni del Procuratore Generale di S. M. nella causa vertita tra Valenza, Bozzole e Marchesi Angela e Giuseppe, madre e figlio Della Valle».
Sono sempre state vigorose anche le tensioni nello stabilire i confini di Valenza nei confronti di altre terre, lontane dal Po, analogamente soggette al Ducato di Milano, come Alessandria, e ancora più per fissare i confini verso altri feudi contigui.
Sembrava favorirne le mosse, la faciloneria e il caos sempre dilagante nella zona di Valmadonna – borgo in zona di confine, la cui nascita è da collocarsi attorno all’XI e XII secolo – che si poneva in contiguità delle comunità di Borgoglio o Bergoglio – in origine Bergolium, una delle terre più antiche di Alessandria – e di Astiliano. Probabilmente Artigliano era un villaggio molto antico, che in seguito si dislocò, in parte, verso il fiume Po e poi diventò la nostra Valentia.
Forse la disputa territoriale con Alessandria era meno acuta poiché in questo caso il confine non era quello del ducato, giacché dal XIV secolo entrambe appartenevano ai Visconti di Milano. Era una questione di natura diversa dalle precedenti, poiché quelle di S. Salvatore, Bozzole e Lazzarone erano vere questioni di confini di Stato, che talora avevano anche conseguenze politiche, mentre nel caso di Alessandria si trattava di due comuni di uno stesso Stato.
Alessandria sosteneva da qualche tempo che il suo confine comunale a Valmadonna doveva coincidere con il sedime della strada della Serra, linea di cresta che attraversa le colline del Po da est a ovest sino al Basso Monferrato. Valenza, invece, riteneva che il suo comune fosse detentore dell’intera cresta sino a una parte della collina sottostante, in una via che si chiamava appunto via oltre la Serra. Non era un vituperio, una villania o un problema politico, bensì una questione giuridica-economica al fine di poter esigere taglie comunali, d’imporre obblighi, prebende e altro ancora. Ma al tempo stesso è evidente che, dietro l’immagine cortese della lunga divergenza, era vivida, anche se velata, una certa combattività tra i due comuni che trasudava finalità punitive.
Nel 1561, un commissario delegato inviato da Milano e strattonato dalle parti in gioco, dopo un’ispezione oculare in tempi serrati, chiudeva le porte ad altri rinvii e, con una strategia non troppo chiara e con alcune furbizie, una specie di bluff nascosto, decideva in favore degli alessandrini. Questo fu un boccone avvelenato per i valenzani, che, con un margine negoziale più limitato, dapprima rigettarono la sentenza sostenendo che la misurazione del territorio alessandrino era sbagliata e poi, non senza un certo dispiacere e sentimenti di sdegno, furono costretti ad accettarla definitivamente il 2 giugno 1561, con atto piuttosto vago rogato dal notaio Pietro Paolo Del Pero tra le deputazioni dei due comuni, perché in quel tempo era la forza che di solito fondava il diritto.
Già nel 1557, quando Valenza era stata conquistata dai francesi del maresciallo De Brissac (tornerà spagnola tre anni dopo), il governatore Francesco Bernardino Vimercati si accordò con il governatore-luogotenente di Alessandria, Rodrigo Gonzales di Salamanca, affinché tra i due territori avversi (essendo Valenza sotto il governo francese e Alessandria sotto quello spagnolo, in guerra tra loro) i valenzani e gli alessandrini potessero liberamente recarsi dal 20 giugno a tutto dicembre nell’altro Comune: qualora ivi possedessero beni, allo scopo di raccogliere i frutti del suolo. L’accordo, presto evaporato, che invocava l’autorevolezza dello Stato, fu stipulato con coro devozionale nella chiesa della B. V. delle Grazie sul confine tra Bergoglio di Alessandria e il territorio valenzano: un risultato meramente formale.
Nel XVI secolo, una serie di piene del Po creò un nuovo braccio che andò a scorrere accanto a Valenza, ove prima c’erano i boschi, dando origine al cosiddetto «Isolone» e aggiungendo pure territori all’altra sponda per la gioia dei confinanti frascarolesi. La circostanza, a geometria variabile, procurò una sequela di liti con i vicini, dal momento che il controllo amministrativo del corso d’acqua assicurava un notevole gettito fiscale per i transiti da una sponda all’altra, ma specialmente per la navigazione.
L’area sottostante Valenza, delimitata da canali secondari o dal corso principale secondo la stagione, oggi conosciuta appunto come l’Isolone, è un territorio alquanto esteso che si allunga anche sulla sponda sinistra del fiume, a prescindere dalla posizione del greto, che è sempre stato considerato dalla città una sua proprietà. Tale è la rilevanza che il Comune, in quei tempi, manteneva uno specifico ufficiale designato al controllo. Ovviamente, questo stato di cose non fu mai accettato dalla comunità di Frascarolo, sia per i diritti di passaggio, sia per l’opportunità di pesca, sia per il fatto che uno spostamento verso nord del fiume avrebbe posto i valenzani nella condizione favorevole di esigere territori sempre più vasti che prima non appartenevano a loro.
Agli inizi del Cinquecento, dopo la variante del fiume, un fenomeno immanente e ineluttabile, accadde davvero di tutto. Frascarolo, raggruppandosi in una specie di trust con Bozzole e altre comunità vicine, iniziò ad aggredire gli abitanti di Valenza. Il 25 aprile 1514, una banda di armati frascarolesi, pronta ad approfittarne e definita dai valenzani un prodotto di Satana, dando segni di schizofrenia, occupò l’Isolone, scacciando i valenzani che si trovavano nei loro possessi di oltre Po. Valenza ricorse al Capitano di Giustizia di Milano che, con un realismo ruvido ma incisivo, confermò alla città il possesso dell’Isolone. Ma la lite non si risolse e, anzi, si alimentò il fuoco.
Il luogo era ormai diventato un campo di battaglia, l’inimicizia tra le parti era sempre più esacerbata e continuò con aggressioni, risse, uccisioni, che culminarono nel 1540 con una scorreria di valenzani a Frascarolo che provocò la distruzione di alcune abitazioni, date alle fiamme.
Quest’angoscioso evento, uno scontro fratricida senza esclusione di colpi, unito a tante altre cialtronerie, pose i feudatari di Valenza (Gattinara Lignana) e l’amministrazione di Frascarolo di fronte alla necessità di calmare la cittadinanza e di trovare un accordo, che fu ufficializzato con una convenzione nel 1545, in cui veniva rivolta anche una supplica all’Imperatore Carlo V e al suo luogotenente del Ducato di Milano, nonché al Senato milanese, affinché fosse concessa la grazia per i delitti commessi.
In essa, i sindaci di Frascarolo dichiararono di rinunciare a ogni diritto e azione sul fondo dell’Isolone e parimenti il conte Mercurino II Gattinara Lignana, feudatario di Valenza, cercando di rammendare, comprò dal suo stesso comune, quello di Valenza, 250 moggia d’Isolone e li cedette in forma benevola al municipio limitrofo, trasferendo il terreno agli amministratori di Frascarolo Alessandro Ungaresi e Castellino Beretta, che non potevano in futuro venderli o trasferirli ad altri, se non a Valenza.
Si stabilì inoltre, sia pure metaforicamente, un confine inamovibile anche in caso di altra deviazione del fiume. Il 12 febbraio 1545, il conte Mercurino II, i sindaci Domenico Bernardino “Sachus” e Giovanni Vincenzo “de Pirro” e il pretore Massimiliano “Perbonus” furono presenti per Valenza alla stesura di quest’atto, stilato in forma abnorme e vessatoria poco adeguata alla questione, ma, come il solito, con estrema arroganza, scarsamente rispettato in seguito. Rimanendo agganciati alla permanenza del problema e attestando non un vincente ma due sconfitti. Come tutte le belligeranze era più facile che s’innamorassero che si comprendessero davvero.
C’è poi l’aspetto più sorprendente e nello stesso tempo sconfortante della faccenda che infiammò lo scontro. I risentimenti erano tali che i frascarolesi proseguirono finanche a negare ai valenzani il passaggio sulle nuove terre, facendosi beffe delle istituzioni e degli accordi. Un incendio mentale che ha intossicato qualsiasi riflessione, che si può quasi quantificare come un esaurimento nervoso permanente e una vera e propria pulizia etnica. Si continuò a detestarsi ancora per parecchio tempo poco cordialmente cercando rogne, senza riuscire a porre rimedio, senza brillare di acume e senza essere in grado di rispettare gli accordi che si erano dati. C’era anche chi andava a caccia di motivi per tenere aperte le ostilità.
Nel 1583, sorse una lite tra Valenza e Bassignana per il possesso di Zerbola, una terra sulla riva sinistra del corso d’acqua di fronte a Bassignana, isolata dal centro abitato e come Valenza facente parte del ducato milanese. Il delegato super partes e sedicente illuminato senatore, il più lucido della compagnia, Luigi Bellone, decise in modo draconiano, per non lasciare spazio a dubbi e per spegnere certi fuochi dell’estremismo, ottenendo quello che sedicenti mediatori non avevano nemmeno sfiorato, di assegnare Zerbola a Borgofranco, che ne prese possesso il 30 settembre 1583.
Per una specie di grossolana nemesi Il borgo sarà poi totalmente distrutto da una piena alluvionale nei primi anni dell’Ottocento e, abbandonato e ricostruito, diventerà poi Suardi sulla comoda e appagante sponda frontale, incenerendo pian piano torti e ragioni spesso grottesche.
Ma non é terminata qui: in questo florilegio di amanti della pace, in una società ipocrita dove il pacifismo era pura utopia, le beghe che trasudavano odiologia fondata sull’autodisprezzo tra i nostri paesi vicini non ebbero fine fino al secolo scorso.
Anche se è difficile trarne conclusioni univoche e i dettagli più sanguinolenti non sono quasi mai stati pubblici, mica si poteva star sempre lì a battibeccare rinchiusi in un ringhioso decadente vittimismo. L’etica ormai imponeva di saper conseguire il giusto compromesso.
Goethe scriveva che gli italiani, «animati da un singolare spirito di campanile, non possono soffrirsi a vicenda».